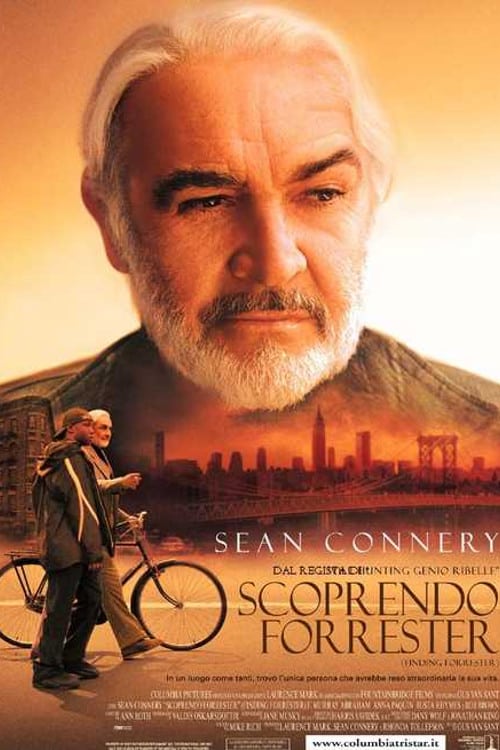Shutter Island
- Martin Scorsese
- Ben Kingsley, Elias Koteas, Emily Mortimer, Jackie Earle Haley, John Carroll Lynch, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Max von Sydow, Michelle Williams, Patricia Clarkson, Ted Levine
- Drammatico, Giallo, Netflix, Thriller
- Stati Uniti
- 14 February 2010
Recensione
Esistono opere minori di grandi maestri del cinema, così definibili non perché prive di suggestioni o di colpi di genio, ma soltanto per qualche disomogeneità che magari non ci si attenderebbe da un acclamato regista.
Shutter Island, tratto da un libro di Dennis Lehane, trasposto dalla sceneggiatrice Laeta Kalogridis, appartiene, in apparenza, a tale categoria, ma non è detto che da dietro la macchina da presa l’accorto Martin Scorsese non abbia di proposito semplificato alcune sequenze per contrapporle ad altre, più enigmatiche e allucinate (molti i momenti onirici “concentrici”), che rendono il film più appetibile, allo scopo di creare una sorta di altalena emozionale che conduca al liberatorio epilogo.
Insomma, uno stile arditamente ricercato. Il plot, calato nel 1954, segue le indagini di una coppia di detective federali, Teddy Daniels e Chuck Aule, in trasferta su una minacciosa isoletta, sede di un manicomio criminale; da qui avrebbe inspiegabilmente tagliato la corda una paziente, assassina dei propri figli.
Man mano che, fra sopralluoghi osteggiati da degenti nervosi e, soprattutto, da sibillini e diffidenti medici e guardiani, la trama si dipana, non è tanto – in riferimento ai succitati “cambi di velocità” – la (volontaria) dispersione di indizi a rendere perplessi, eventualmente viene voglia di soffermarsi sulla piatta scena nella grotta, sulla mancata corrispondenza alla realtà di ogni figura “sognata” o sulla trascurata faccenda del foglio di ricovero.
Ad ogni modo, quasi tutti i tasselli tornano a posto nel finale, lasciando peraltro sul tavolo temi non secondari: i cruenti e profondi solchi dell’olocausto, la coscienza della pazzia, l’elaborazione del lutto con conseguenti rimozioni e ricostruzioni, la necessaria autonomia nelle decisioni di ciascuno.
Abbastanza per dirsi più che soddisfatti.